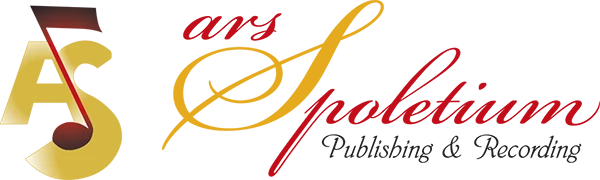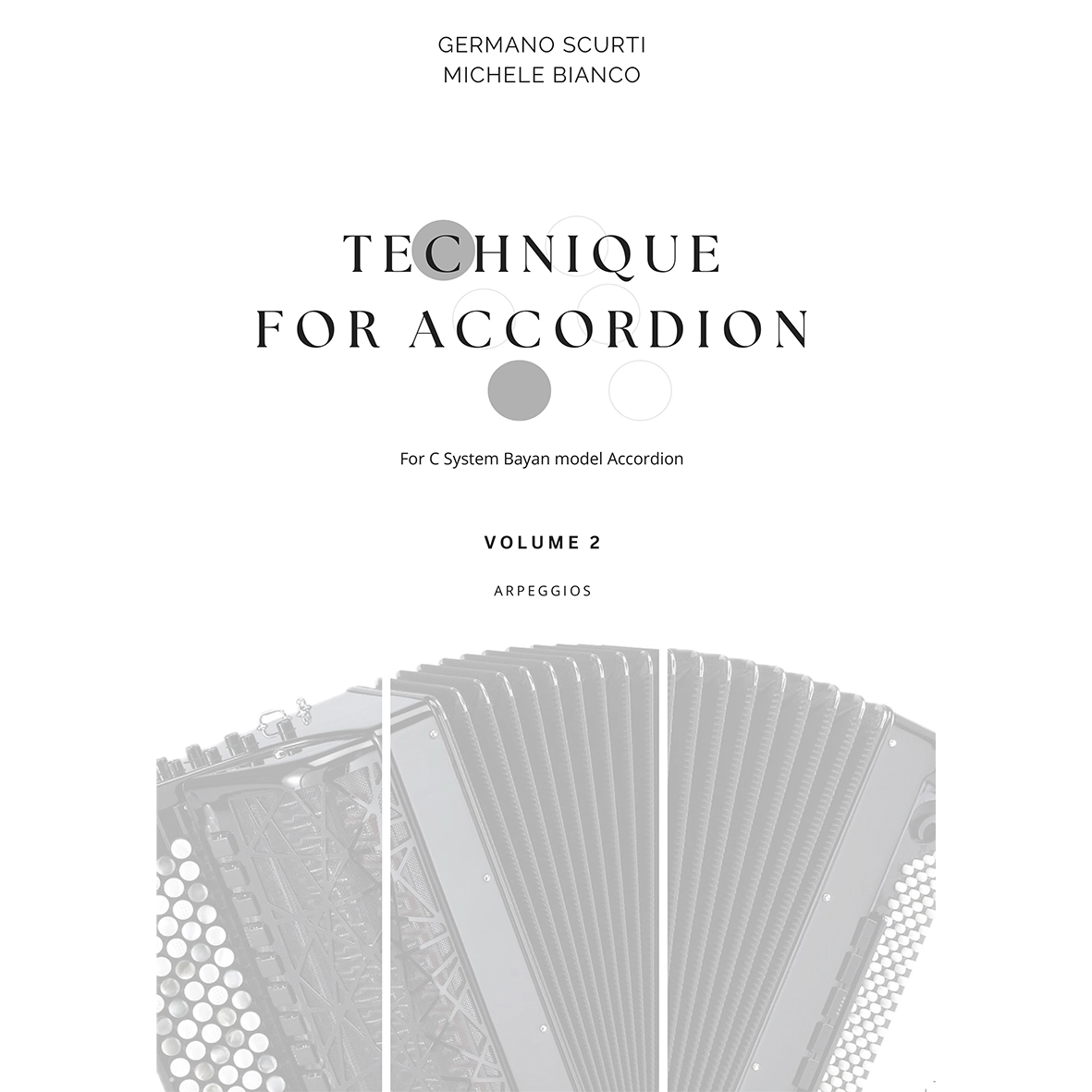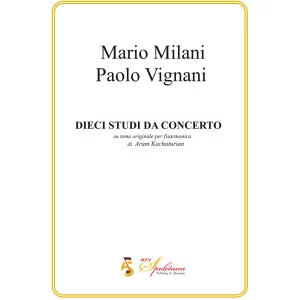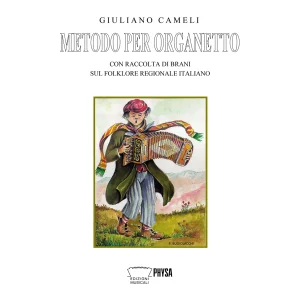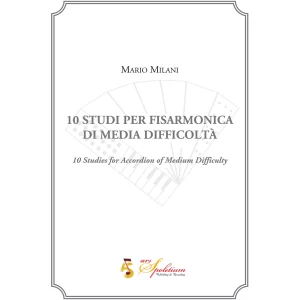Technique for Accordion – for C System Bayan modern Accordion vol. 2
24,00 €
L’attenzione che in anni recenti viene rivolta alla fisarmonica e la contestuale crescita quantitativa in Italia dei corsi nei Conservatori hanno realizzato una obiettiva convergenza nel dare spinta all’offerta editoriale nel campo della didattica per questo strumento.
Eppure, se da una parte la moltiplicazione dei titoli editoriali rappresenta un trend positivo, dall’altra il rischio della frammentazione dell’offerta – fino al paradosso di avere un numero di testi di base, di manuali, metodi, ecc., corrispondenti al numero dei corsi – non è un aspetto che andrebbe trascurato.
Ad Alessandro Di Zio e Vladimir Zubitsky
Premessa
L’attenzione che in anni recenti viene rivolta alla fisarmonica e la contestuale crescita quantitativa in Italia dei corsi nei Conservatori hanno realizzato una obiettiva convergenza nel dare spinta all’offerta editoriale nel campo della didattica per questo strumento.
Eppure, se da una parte la moltiplicazione dei titoli editoriali rappresenta un trend positivo, dall’altra il rischio della frammentazione dell’offerta – fino al paradosso di avere un numero di testi di base, di manuali, metodi, ecc., corrispondenti al numero dei corsi – non è un aspetto che andrebbe trascurato.
A mio avviso, questa possibilità si configura come rischio in due sensi:
– sotto il profilo editoriale, con la contrazione del numero di copie vendute per titolo
– sotto il profilo didattico, con un calo significativo degli scambi fra corsi e docenti e la mancanza di testi in grado di funzionare da riferimento condiviso, sostituito da una miriade incontrollabile di riferimenti locali.
Nello stesso tempo, abbiamo assistito a una crescita e a una decisa articolazione delle qualità tecnico-strumentali richieste a un fisarmonicista – in particolare a chi suona il sistema cromatico modello-bayan. Strumentista, non più confinato nella musica popolare, o in quell’ampio panorama di semi-professionismo che ha dato i natali a molte opere didattiche ancora in circolazione, che si trova di fronte a una crescente e impegnativa letteratura originale, collocabile nell’ampio panorama classico-contemporaneo, e che in quanto tale non sembra trovare una risposta adeguata negli attuali titoli didattici.
Ecco, il lavoro che qui si presenta, un’opera in tre volumi, specificamente dedicata alla “tecnica digitale” per fisarmonica modello-bayan c-griff, è stato concepito per provare a rispondere non solo alla frammentazione indicata, ma soprattutto allo scopo di andare incontro alla quanto mai urgente esigenza di una crescita qualitativa delle opere didattiche. Crescita che trova, a mio avviso, nella valorizzazione delle specificità la risposta più adeguata.
Il compito che mi sono prefisso con questo lavoro consiste proprio nel provare a rispondere all’esigenza di strumenti didattici specifici per fisarmonica modello-bayan c-griff. Seguendo, in questo, una strada aperta, almeno in Italia, da Claudio Jacomucci con la sua Tecnica I, a cui va attribuito un doveroso riconoscimento.
Sappiamo che la letteratura didattica esistente non fa distinzione tra i diversi modelli di fisarmonica. Si tratta appunto di una indistinzione che porta ad opere didattiche generiche e nella maggior parte dei casi, dal mio punto di vista, dai risvolti non solo insufficienti ma alquanto dannosi: la posizione diatonica dell’Hanon, ad esempio, posizione di partenza che consente la massima rilassatezza nel sistema “pianoforte”, applicata al sistema “cromatico” porta invece a una costrizione e a un irrigidimento del tutto “innaturali”, con effetti indiscutibilmente negativi. All’indistinzione tra i diversi modelli di fisarmonica si aggiunge poi la velleità dilettantesca di scrivere manuali, metodi, che in poche pagine vorrebbero esaurire l’intero spettro, l’intero scibile, delle necessità tecniche di uno strumento così complesso come la fisarmonica classica.
Ho trovato dunque necessario uscire da questa genericità valorizzando, focalizzando e approfondendo precise specificità tecnico-strumentali, nella speranza che la nuova generazione di strumentisti e insegnanti che vanno dai trenta ai quarant’anni, a cui io stesso appartengo, nello sfondo di una progettualità comune, possa non solo apprezzare tale tentativo ma soprattutto
dedicarsi anch’essa, mettendo a frutto le proprie indubitabili qualità, alla ricerca, produzione e distribuzione di opere didattiche specifiche per bayan.
Il lavoro a cui mi sono dedicato in questi tre volumi si riferisce appunto all’individuazione e articolazione di tecniche di base e avanzate specifiche per fisarmonica modello-bayan c-griff utili allo sviluppo di ciò che si definisce “tecnica digitale”.
Ho cercato – a partire da questo primo volume dedicato allo sviluppo dell’uguaglianza, della forza e dell’indipendenza delle dita, per proseguire con un secondo volume dedicato agli arpeggi e con un terzo alle scale – ho cercato, dicevo, di sviluppare una pluralità di esercizi, concepiti come parte fondamentale della pratica quotidiana di un fisarmonicista, in grado di portare allo sviluppo “razionale” delle qualità tecnico funzionali, qualità necessarie a produrre risultati esecutivi consapevoli e sicuri.
Si tratta dell’applicazione di una pratica, di una tecnica, che si contrappone alle forme di insegnamento empirico, che procede solitamente per tentativi ed errori, per risvegliare l’intelligenza e la volontà sulle cause “determinanti” del tocco, della velocità dei movimenti, dell’agilità, della sicurezza nell’esecuzione di un passaggio e di un brano. Circostanze che si possono realizzare assai difficilmente se l’esecutore procede a un pratica-allenamento incosciente e si affida solo al prolungato esercizio.
Scrive Czerny nella prefazione a Scuola di velocità: “Fra le buone qualità che si richiedono a un pianista, la prima è l’agilità che è il fondamento di tutta l’esecuzione”.
Agilità che trova tuttavia la sua causa “determinante” nella cosiddetta indipendenza, nella dissociazione muscolare, cioè nella capacità con cui possiamo contrarre determinati tendini e muscoli. La vera agilità è appunto l’agilità contrattile che dipende dalla dissociazione muscolare, sviluppabile solo da una pratica “razionale” e intelligente. Questo è lo scopo dei miei tre volumi dedicati alla “tecnica digitale”: la disciplina delle contrazioni muscolari, lo sviluppo dell’agilità contrattile, da cui dipende la sicurezza dell’esecuzione e la velocità.
Il che vuol dire che gli esercizi sul tremolo, ad esempio, non vanno concepiti come utili semplicemente a risolvere i problemi che può porre la Sequenza XIII di Luciano Berio o alcuni passaggi di Episoden, Figuren di Mauricio Kagel. Come gli esercizi sul trillo non sono in funzione di una migliore esercuzione di alcuni momenti di De Profundis di Sofia Gubaidulina. Oppure, gli esercizi sul ribattuto per affrontare le difficoltà di The Flight Beyond the Time di Petri Makkonen. E’ chiaro che una corretta applicazione porterà a risultati positivi anche in questa direzione. Ma lo scopo principale di questi esercizi è legato a una pratica quotidiana necessaria allo sviluppo di qualità tecnico-esecutive funzionali di carattere fondamentale.
Questa via richiede in apparenza maggior tempo e pazienza di quella seguita generalmente. In realtà, l’acquisire qualità funzionali fa guadagnare tempo, perchè chi possiede i mezzi necessari per affrontare l’esecuzione, perviene allo scopo assai più rapidamente e meglio di chi vi giunga a forza di tentativi e di ripieghi. Chi prolunga l’esercizio senza saper studiare, anziché perfezionarsi, peggiora, poiché il suo sistema funzionale, invece di modificarsi nel senso più opportuno, si fissa nell’errore.
Mi sembra inoltre importante che l’allievo-strumentista acquisisca autonomamente una sufficiente nozione dei rapporti esistenti tra cause ed effetti. La costanza nella pratica deve avere origine dal sapere quale giovamento la cura stessa ci può produrre.
Per questo, è importante sapersi ascoltare con molta attenzione, studiare lentamente, spostare e variare gli accenti ecc. In una parola, è necessario fare un lavoro paziente, intelligente, di riflessione. Senza trascurare il fatto che da una predisposizione di questo genere, che si prende cura, attraverso una pratica quotidiana, delle proprie qualità funzionali tecnico-esecutive, passa anche l’abitudine, quanto mai apprezzabile, a una più generale pratica di Cura del Sé.
Desidero ringraziare Andrea Manzoli, Gianni Torlontano e Massimiliano Pitocco, rispettivamente un compositore, un pianista e un fisarmonicista-bayanista, per il loro amichevole incoraggiamento e sostegno e per i loro sagaci suggerimenti che hanno stimolato la mia non sempre pronta immaginazione. Ciò conferma il fatto che da soli non si va molto lontano, e che lo scambio, il riconoscimento reciproco e il dialogo sono le uniche strade per migliorare. Resta mia naturalmente la responsabilità per tutto ciò che si trova in questi volumi. Il debito maggiore l’ho comunque contratto con Andrea Manzoli. A lui – oltre che all’editore -, alla sua competenza e generosità si deve la pubblicazione di quest’opera.
Dedico infine questo lavoro ad Alessandro Di Zio e Vladimir Zubitsky. Al primo per la sua guida sapiente: maestro nei confronti del quale non è facile esprimere tutta la mia gratitudine per il suo prezioso magistero. Come profondo e illuminante, nella maturità, è stato il confronto con Vladimir Zubitsky, riferimento esemplare per quanti condividono l’interesse per il bayan. Ad entrambi va tutta la mia riconoscenza.
Pescara, maggio 2007
Prefazione alla nuova edizione
Sono passati esattamente quindici anni dalla prima edizione del primo volume di questa opera didattica specificamente dedicata alla “tecnica digitale” per fisarmonica modello bayan c-griff, il progetto prevede tre volumi. Un tempo che da una parte ha confermato i bisogni da cui nasce, ovvero la necessità di una pratica quotidiana in grado di portare allo sviluppo “razionale” delle qualità tecnico funzionali di un fisarmonicista, dall’altro ha in qualche modo convalidato la specificità delle risposte a quei bisogni che questi tre volumi sono in grado di offrire. Un tempo dunque che ha messo alla prova l’impianto dell’opera non solo su me stesso ma anche attraverso una decennale attività didattica. Ecco, ad oggi, proprio per questo, siamo in grado di proporla, al momento solo nei suoi primi due volumi, forse con una più decisa convinzione.
E ringraziamo il nuovo editore Gianluca Bibiani che ha voluto crederci insieme a noi. Il tempo non ne ha intaccato l’impianto. In questa nuova edizione, nel primo volume, ho solo modificato alcuni dettagli per rendere in qualche modo più fruibile e attenta l’applicazione degli esercizi. In particolare, ho cercato di sviluppare maggiormente l’utilizzo della tecnica parallela (stessa diteggiatura tra manuale destro e sinistro). Niente di più. Abbiamo invece in prima edizione la pubblicazione del secondo volume che dedica la sua attenzione primaria agli arpeggi. Un volume, come immagino e spero anche il terzo, che beneficia anche del contributo di Michele Bianco, il mio primo allievo che si è misurato con quest’opera, che ne ha fatto il fondamento della sua pratica quotidiana, e che oggi ne restituisce l’esperienza anche in forma di scrittura. A testimonianza non solo del percorso didattico decennale di quest’opera ma anche, ed è un discorso che non possiamo dispiegare in questo contesto, ad attestare quanto gli insegnanti possano ricevere dai loro allievi, se sono attenti ai feedback vitali che gli restituiscono e quanto fondamentale sia nel processo formativo innescare una relazione intensa che non può mai essere unidirezionale ma di attenzione congiunta, una relazione appunto in cui si misura non solo la responsabilità dell’insegnante ma anche la sua inevitabile responsività. Ecco, è proprio l’intensità di questa relazione che mi porta a vivere con il massimo entusiasmo la mia esperienza didattica e che supporta i principi di base di quest’opera. Con la speranza che se ne possano cogliere i benefici.
Pescara, gennaio 2022